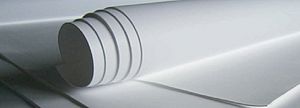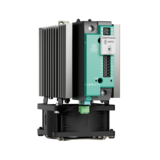Dieci anni circa di tentativi di ricomporre ciò che si è incrinato nel sistema socioeconomico forse non sono ancora bastati per mettere a fuoco una realtà che la scienza ha evidenziato ormai da tempo: guardare il mondo in maniera meccanicistica e non olistica restituisce un’immagine distorta del suo funzionamento. Questo vale per la natura, come per l’essere umano e qualsiasi sua forma di organizzazione.
Concentrandoci sulle aziende, dove spesso organigrammi a matrice raccontano la visione per gerarchie e per funzioni su cui ancora poggia la realtà aziendale, in generale, è evidente a quali scarsi risultati abbiano portato negli ultimi anni programmi di cambiamento di tutti i generi. Come sostiene Sir Kenneth Robinson, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo dei sistemi educativi e di sviluppo di capacità individuali, siamo di fronte «all’altra crisi climatica», quella delle risorse umane, perlopiù demotivate, impaurite se non alienate da un modello del lavoro troppo spesso privo di un senso.
Basta guardarsi un po’ in giro per rendersi conto, con sconcerto: «la prevalenza di politiche del personale basate su un criterio quantitativo piuttosto che qualitativo. Tutte le teorie economiche individuano tre fattori chiave per valorizzare il capitale umano: capacità, lealtà e trasparenza». Bastano solo queste condizioni e si diventa davvero competitivi, perché aumenta l’impegno delle persone e quindi la loro dedizione al lavoro, ma ahimè non si vedono in giro molti casi positivi in tal senso. Sembra sia maggiormente praticata la modalità che utilizza “la paura della sanzione” che spinge a comportamenti “virtuosi”. Ma è anche vero che se si guarda a numerose indagini internazionali sulle nuove generazioni, emerge una tendenza molto forte: in una recente indagine internazionale di Deloitte, l’87% dei Millennials presi in esame ritiene che il successo di un business dovrebbe misurarsi in termini non solo finanziari e che un’azienda va giudicata sulla base di quello che fa e di come tratta le persone.
Le potenziali conseguenze in termini di scelte di consumo e di preferenze di organizzazioni in cui lavorare potrebbero portare a una progressiva pressione sociale sui comportamenti delle società. A registrarla per prime sono le grandi realtà multinazionali o internazionalizzate che, pungolate dalla trasformazione digitale, stanno iniziando ad affrontare in maniera diversa la gestione del personale. «Stiamo rilevando uno scatto di consapevolezza nelle aziende che le porta a rivedere i processi interni di gestione delle risorse umane e ad adottare una vera people strategy, indirizzata allo sviluppo delle persone e delle competenze richieste da Industry 4.0» spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation practices della School of Management del Politecnico di Milano. In effetti, dall’ultima ricerca dell’Osservatorio emerge che il 61% delle organizzazioni italiane prese in esame ha previsto già dal 2016 un budget dedicato a nuove iniziative digitali nelle risorse umane, soprattutto nei processi di valutazione delle performance, alla formazione e alla selezione del personale.
C’è da dire che si tratta di un’analisi empirica condotta su un centinaio di HR executive di medio-grandi aziende operanti in Italia. Ma, in ogni caso, «intercetta la tendenza alla trasformazione del direttore del personale in un business enabler – spiega Corso – e a un committment del Ceo molto alto, perché è chiaro ormai a tutti che per essere competitivi il capitale umano, oggi, è quasi più importante del capitale finanziario». Eppure, questo non è sufficiente se non si riesce a rispondere al profondo bisogno di motivazione delle persone. Il quadro emerso dal Gallup Report, condotto ogni anno su 160 nazioni del mondo, è impietoso: in Italia, l’indagine stima che solo il 14% delle persone che lavora sia soddisfatto, a fronte di un 68% che non lo è e di un 18% impegnato nel mostrare e trasmettere il loro malessere ai colleghi.
Ma l’allarme investe tutti i Paesi esaminati. Secondo l’interpretazione di Frederic Laloux, già associate partner di McKinsey, abbiamo bisogno di sviluppare nuovi modelli organizzativi in sintonia con lo stato di evoluzione della coscienza umana in cui stiamo entrando. Numerosi studiosi di diverse discipline hanno dimostrato che nella storia dell’umanità siamo passati attraverso vari stadi che hanno generato, ogni volta, nuove forme di collaborazione adatte a quella realtà. Lo stadio attuale richiede l’«addomesticamento del nostro ego» e un modo di essere più autentico e completo.
Nel suo lavoro di ricerca, Laloux ha individuato e studiato una dozzina di organizzazioni, da cui ha tratto il profilo di un modello emergente basato su tre fattori: self- management (autonomia attraverso una leadership diffusa), wholeness (pienezza dell’identità delle persone), evolutionary purpose (costruzione di uno scopo collettivo). «Laloux offre una cornice strutturata a pratiche che in parte già esistono, come ad esempio innovativi piani di welfare – commenta Tiziano Capelli, partner di Peoplerise che ha tradotto in Italia il libro di Laloux Reinventare le organizzazioni, GueriniNext –, ma che è importante riconoscere e inquadrare in una visione complessiva. Ogni azienda può partire da dove le risulta più facile e congeniale, sperimentando modalità di lavoro diverse in un ambiente protetto, per verificarne la funzionalità». Secondo Capelli, soprattutto tra le PMI, c’è un buon fermento. «Spesso però», dice, «capita che le aziende non abbiano messo bene a fuoco la loro “filosofia” e finiscano per tradirla. Non si tratta di aggiungere qualcosa, ma semmai di fare un’operazione di pulizia interiore per riscoprire e valorizzare l’anima che già c’è».
Sono praticamente nato lavorativamente nel mondo manutentivo e l’ho vissuto a tutti i livelli, da quello più basso (operaio liv. 2) nel 1980 passando alla gestione di una squadra di manutentori, fino ad arrivare al passaggio nei sistemi informatici negli anni ‘90, dove per un “allineamento di pianeti” mi sono trovato a sviluppare un software ad hoc per i manutentori e non solo. Un manutentore per i manutentori. Ma la cosa che la mia più che quarantennale esperienza mi ha insegnato è che nel mondo della manutenzione sono prima le persone a dare un apporto indispensabile al mantenimento dei vari impianti. Il resto, sempre importantissimo, viene però a corredo.
Proviamo a definire il significato di manutentore. La Treccani ci dice: “manutentóre s. m. e agg. (f. -trice) [tratto da manutenzione]. – Chi cura la manutenzione di un impianto, di una macchina e sim.” La Garzanti: “manutentore [ma-nu-tentó-re] agg. e n.m che, chi provvede alla manutenzione di qualcosa: impresa manutentrice." Direi che siamo molto vaghi… Che dire poi delle scuole di manutenzione? Se cerchiamo in internet “Scuola di manutenzione” avremo un elenco infinito di scuole per manutenzioni specifiche… questo mi porta a pensare che la scuola più importante la frequenti sul campo. Che la si chiami “formazione on the job” o “formazione integrativa”, è dall’esperienza di colleghi navigati che puoi ricevere le lezioni migliori. In questi lavori la crescita graduale in azienda è fondamentale, per questo il neoassunto inizia dall’affiancamento per poi passare al ruolo di aggiustatore, montatore meccanico, installatore e, infine, responsabile della manutenzione meccanica o elettrica o altro…
Fra le competenze più richieste:
- Capacità di analisi e di problem solving. Come abbiamo visto, per rimediare a un guasto non basta conoscere la teoria, bisogna avere spirito d’osservazione e individuare la soluzione migliore per il caso specifico. In questa dinamica, la propensione al problem solving è un asso nella manica, capace di agevolare in questo genere di operazioni.
- Rapidità di intervento. “Il tempo è denaro”, soprattutto se la catena produttiva dipende da te. Ecco perché in questa professione l’essere veloce – non solo nell’analisi ma anche nella riparazione – è una caratteristica molto apprezzata e ricercata. Ecco qui che abbiamo l’evidenza di come l’esperienza sia fondamentale. Ricordiamo ora la definizione di capitale umano.
Capitale umano. Insieme di capacità, competenze, conoscenze, abilità professionali e relazionali possedute in genere dall’individuo, acquisite non solo mediante l’istruzione scolastica, ma anche attraverso un lungo apprendimento o esperienza sul posto di lavoro e quindi non facilmente sostituibili in quanto intrinsecamente elaborate dal soggetto che le ha acquisite. Pur non potendo essere misurate univocamente, le componenti del c. u. determinano tuttavia la qualità della prestazione erogata dal detentore, concorrendo ad aumentare la produttività di un’impresa e a qualificarla, influenzandone i risultati (Sempre da Treccani). - Capitale umano come patrimonio dell’impresa. Investire in c. u. significa, da parte di un’azienda, curare la formazione professionale e tecnica dei propri dipendenti; così come disperdere, sprecare un rilevante c. u. corrisponde a una utilizzazione solo parziale, malaccorta o improduttiva delle conoscenze e competenze dei propri collaboratori. In questo senso, il c. u. si riferisce anche all’insieme di quelle capacità e abilità che consentono l’ottenimento di un reddito da parte dell’individuo che le possiede. Il reddito percepito dagli individui in cambio della prestazione dei loro servizi è pertanto interpretato come remunerazione del loro c. u. Le spese destinate all’accrescimento delle conoscenze, capacità e abilità (per es., le spese destinate all’istruzione) degli individui sono investimenti in c. u. Si stabilisce così una particolare analogia fra c. u. e c. non umano (attrezzature e impianti). Gli investimenti in c. u. sono destinati ad accrescere la capacità produttiva e i redditi degli individui; gli investimenti in c. non umano sono finalizzati all’incremento delle capacità produttive e dei redditi delle imprese. Resta tuttavia fondamentale la differenza, per quanto concerne i titoli di proprietà, di questi due tipi di capitale. Il c. u. può essere posseduto solo dall’individuo in cui esso è incorporato e non è alienabile tramite compravendita; il titolo di proprietà del c. non umano può essere invece oggetto di scambio sul mercato.
Evoluzione del concetto di capitale umano. Sebbene indicato con termini diversi, il concetto di c. u. è stato a lungo familiare agli economisti, ma è solo a partire dagli anni ‘60 che è stato sviluppato e ha ricevuto notevole attenzione. Contributi di particolare rilievo si debbono a T.W. Schultz, G. Becker e J. Mincer. Il concetto è stato inserito in un’analisi generale del comportamento umano basata sui principi di fondo della razionalità economica. Negli anni ‘80 e ‘90, questo tema è oggetto di rinnovato interesse da parte dei teorici della crescita endogena che considerano il c. u. uno degli argomenti della funzione di produzione e sottolineano l’interdipendenza fra crescita economica e sviluppo del c. umano. In tal senso, programmi di addestramento e riqualificazione contribuiscono all’aumento del c. u., favorendo così l’evoluzione del sistema nel suo complesso e le condizioni di reddito dei lavoratori. L’attuale dibattito nella letteratura econ o m i c a individua soprattutto nella conoscenza e nelle competenze individuali gli elementi principali di cui si servono le imprese per mobilitare in maniera integrata risorse interne ed esterne, impegnando forza lavoro più qualificata e adeguata alle esigenze di un Paese a economia avanzata.
Antonio Dusi, Un manutentore per i manutentori