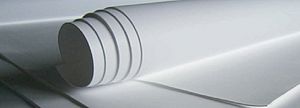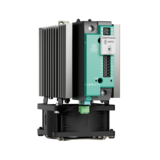Capitolo 4 - Il manutentore Don Chisciotte
Scrivo sul taccuino che fuori sembra voglia piovere, che arrivano da lontano i suoni ostinati dell’acciaieria, che è quasi l’ora del cambio turno e degli uomini entreranno in reparto mentre altri se ne andranno a casa, e tutto il mondo continuerà a muoversi e risuonare. Poi rivolgo ad Alberto uno sguardo che dovrebbe spingerlo a parlarmi ancora, ma, per evitare equivoci, oso il “tu” e dico: - raccontami.- Ricomincia a fissarmi con i suoi occhi chiari e mi offre un noir con uno scenario, una vittima, un’indagine e una lezione che diventa regola.
Scenario: un impianto con ingranaggi in movimento, un carter non riposizionato e una mano.
Vittima: la mano resterà senza dita.
Indagine: gli ispettori fanno domande ai lavoratori presenti al momento dell’infortunio - la loro risposta è stata “ah! ma noi non l’abbiamo messa [la protezione] non perché non serviva, ma perché non era fatta bene; se ce n’era una migliore, noi la usavamo”.
Lezione: - Quello mi ha fatto mettere l’allerta… pertanto a dirmi “qui è meglio che sto attento”, perché quando noi dicevamo di utilizzare una cosa, non serviva a niente, quando poi succedeva qualcosa… le persone… “ah, ma non avete insistito, non l’avete fatta mettere!” tutte le scuse per dire che…- è colpa tua. Ne so qualcosa, caro Alberto, rischia di essere un grosso difetto non riconoscere il male nelle persone, e dopo una, due, tre zampate di tenebra che non ti aspetti una certa sfiducia diventa generalità: - E’ sempre stato così e lo sarà sempre: produzione e sicurezza, è sempre stato difficile riuscire a metterle insieme. Si riusciva, perché poi alla fine lo si faceva; però non è mai stato facile, era molto duro, c’erano grandi resistenze.
È una regola emotiva ed empirica, con un po’ di amarezza come condimento; alcuni potranno capire e godersi questo momento in cui i capelli bianchi e la prudenza non vanno a braccetto; altri semplicemente no, ed è inutile confrontarsi su certe idee di profitto e stili di carriera.
Taccio anche con Alberto, ma forse avrei dovuto parlarne. Mi limito ad annuire, con ampi su e giù della testa, lui coglie e prosegue - produzione e sicurezza sono sempre state un po’ due forze che… uno tirava da una parte e uno dall’altra, poi la risultante era forse quella giusta. – Siamo dentro un pensiero che porta dritto a una metafora: – un’altalena… quello della sicurezza ci mette tre funi per tenerla in piedi; quello della produzione ne vorrebbe mettere solo una… Pertanto, io dico, era la via di mezzo quello che bisognava fare. – Mi rivolge un sorriso mansueto e torna a essere più misurato. La sua voce riprende toni pacati. Alberto è informato, dice cose intelligenti, è di nuovo pronto a calcolare. Mi parla di norme, percentuali, statistiche; riporta cifre e giorni e io immagino linee colorate su magnifici grafici. Oh grafici, i germi del progresso e del successo stanno in voi! Ironizzo? Compatibilmente con il ruolo. Non nascondo che sono stato l’inventore fallito di progetti quali “adotta un carroponte”, né il mio scetticismo verso le cifre, verso la valutazione dei risultati indipendentemente dai percorsi e dai significati. Un po’ è che sto invecchiando, un po’ è il mio modo per non arrendermi al culto del vuoto obiettivo e del vincente a buon mercato. Ma Alberto non bara con se stesso e con gli altri, si assume la responsabilità delle proprie azioni, carica il suo lavoro di contenuti etici e usa l’autorità dei numeri come leva per scegliere ragioni giuste, per indirizzarsi a risultati che comprendano il fare, i processi, i valori, non solo la conclusione. Torna a mescolare il misurabile e l’immisurabile e mi dice così, non lo immagino, lo dice davvero: – C’era una statistica che dimostrava che su ventinove possibilità di infortunio, uno viene grave e un paio vengono leggeri, perché è inevitabile, è proprio una sequenza inevitabile. Pertanto, l’unico modo per evitare questa sequenza era contattare gli operai. – Resto a guardarlo un po’ perplesso, perché, ammettiamolo, il sillogismo non è dei più stringenti, poi capisco che è il tratto antropologico a liberare la frase, a schiodarla dalla bacheca dei grafici: contattare i lavoratori, come un apriti sesamo, per opporsi all’Inevitabile. Lampeggiano magia e fattore umano. – Dovevano capire che anche da loro dipendeva molto; dipendeva molto dal fattore umano – e il bisogno di capire sovrasta quello di misurare – si vedeva che… l’uomo, per quanto io possa sistemare un impianto, rendere sicuro un impianto… se non capivano…– Lascia in sospeso la frase, si contrae sulla sedia, puntella i gomiti sul tavolo e in una manciata di parole getta nel pentolone bollente tutto l’organigramma produttivo: – All’inizio, quando siamo partiti con le riunioni a gruppi di operai, lì è stata dura. Avevo fatto non so se tre o quattro riunioni, ed era dura allora. Ci aggredivano. Io mi ricordo che alla prima sera avevo la febbre, poi, dopo, hanno capito che non eravamo andati per bastonare, ma per aiutare. – Mi si avvicina molto, forse troppo, e mi parla delle riunioni con i capi reparto, degli incontri in Direzione. Lo vedo battere le palpebre quattro o cinque volte, come un tic. È un segno, penso, aspetto e mi racconta della silicosi. Parla a lungo. Immagini potenti, immagini tristi. Poi c’è una pausa che pare infinita. Forse ripensa ad alcune cose che mi ha detto. Forse non le avrebbe volute dire. Forse vorrebbe un po’ correggersi con la frase che a breve riporterò, che pronuncia con una luce di passione negli occhi chiari e scandisce con convinzione e umiltà: - Io-ho-assistito-al-calo-degli-infortuni. Gli ultimi anni era un fatto eccezionale il morto. […] Anche perché lottavano tutti: magistratura, dirigenza, lavoratori… tutti assieme. E poi sa, noi facevamo una parte, ma una parte l’hanno fatta tutti. E’ stato un insieme, perché fossimo stati solo noi… facevamo il Don Chisciotte.- So che dovrei parlare del modello socio-tecnico; della sicurezza come fatto organizzativo, scientifico e culturale. Non lo farò. Ora voglio scrivere che lei, signor Alberto, ha fatto il Don Chisciotte, perché nella sua storia c’è un Ronzinante a pedali; c’è un popolo povero che lei ha voluto vedere come signori di un castello, che ha contattato per opporsi all’inevitabile e si è fatto venire la febbre per loro e ha sofferto per i loro infortuni; ci sono gli scontri con i mulini a vento e battaglie con uomini oscuri; c’è una grande avventura, perché lei ha messo in gioco tutto se stesso e io continuerò a vederla così: nato con i capelli bianchi, in giro per i reparti, manutentore a caccia di guasti sulle macchine e sulle persone.
...continua sul numero di gennaio

“Chi si darà la pena di visitare i laboratori artigiani, vi vedrà ovunque l’utilità unita alle più grandi dimostrazioni di intelligenza”. Estratti dalle tavole Torneria e voce Mestiere, dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
Sarà stato rileggere l’intervista ad Alberto, datata 2014, con i temi che la percorrono, o la recente pubblicazione di Costruire e Abitare, volume di chiusura della trilogia che Richard Sennett ha dedicato all’Homo Faber, non so, ma qualcosa, questa sera, mi ha fatto allungare la mano e riprendere L’uomo artigiano, il primo volume del trittico sennettiano, quello che preferisco. Il titolo, per molti di noi, è già fuocherello che si accende da solo, dentro, e fa luce intensa. Sfoglio, senza troppo fissarmi sul trovare, e mi vengono incontro gli uomini di Gerico, che impastano mattoni di argilla, con paglia e merda, e fanno sorrisi d’intesa ai programmatori di Linux. “Sono tutti artigiani”, scrive Sennet, “a loro sta a cuore il lavoro ben fatto per se stesso”. Ecco l’artigianalità: mettere l’impegno personale in ciò che fai, che costruisci, che aggiusti, sentire l’impulso a svolgere bene il proprio lavoro non riducendolo ai soli fini dell’utilitarismo che imperversa. A differenza di Sennet, io non sono un sociologo, non sono incline alle sintesi millenarie e alle generalizzazioni storiche, ho il chiodo fisso dei frammenti di vita, vai a sapere le ragioni profonde, e ripenso a quell’anno 1992, in cui la diabolica combinazione di adolescenza, scarso impegno e difficoltà nel dominare l’ira, fu lavorativamente gestita affidandomi alle cure di Pino, metro cubo di calabrese d’altri tempi. Così mi ritrovai apprendista di quest’uomo vecchio, senza famiglia, tutto lavoro e osteria, piuttosto cattivo, col nasone e gli occhi piccoli, gonfi, sempre arrossati. Era il fumo del Toscano? Forse. Era il vino abbondante? Forse. Facevamo lavori poco importanti o nascosti o che nessuno avrebbe controllato e mi stupiva l’impegno che dedicava loro. Chiedevo perché tutto quel tempo, tutta quell’attenzione? Pino mi grugniva sempre la stessa cosa: - Perché sì. - Sennett avrebbe capito subito il senso di quella risposta e, teoria degli insiemi alla mano, lo avrebbe accomunato ai liutai, i fabbri, i tessitori del suo libro, al Tino Faussone di Primo Levi, o a Gianfranco Trevisan o l’Alberto stesso, e gli altri, delle mie interviste: sono tutti artigiani, fanno bene il loro mestiere perché sì. Per loro, l’utilità finale non può essere separata dal percorso per raggiungerla, dall’abilità e dall’intelligenza che mettono nel lavoro. A me, per capirlo, sono serviti molti anni, ma io non ho studiato a Harvard, sono andato a scuola da Pino, ho un cervello sottocosto, come le poltrone e i sofà di cui parlava un tizio in televisione, questa sera, appena prima che il Misterioso Qualcosa mi portasse a risfogliare L’uomo artigiano.